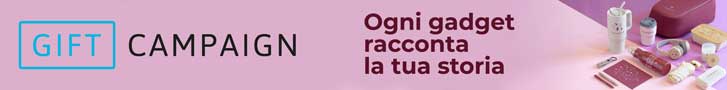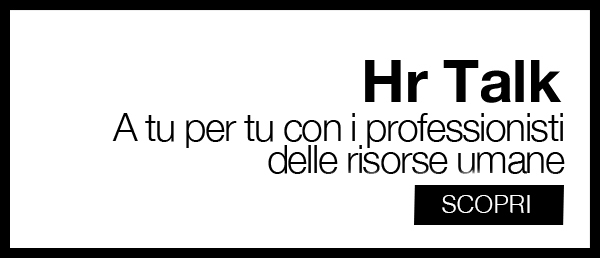Neurodivergenza e people management: che cosa vuol dire per l’HR?
Quando si parla di inclusione lavorativa ci si imbatte sempre più spesso con il termine “neurodivergenza”. Cosa vuole dire, a chi si riferisce e perché è importante parlarne anche in prospettiva legale. In questa puntata di “Includere per crescere” ci concentriamo su questa importante componente della forza lavorativa.

Quanti neurotipi?
La neurodiversità è un termine generico non medico, coniato negli anni 90 dalla sociologa Judy Singer – a cui era stata diagnostica una forma di autismo – partendo dall’idea che “Proprio come l’era postmoderna vede ogni convinzione troppo solida dissolversi nell’aria, anche le nostre supposizioni più scontate: che tutti noi più o meno vediamo, sentiamo, tocchiamo, udiamo, odoriamo e ordiniamo le informazioni più o meno allo stesso modo (a meno che non si sia visibilmente disabili) – si stanno dissolvendo”.
Una ricerca Deloitte indica che tra il 10% e il 20% della popolazione mondiale è considerata neurodivergente.
Le condizioni di neurodiversità includono l’autismo, la disprassia, la dislessia, la discalculia e l’ADHD, tra le altre.
È comune che le persone si identifichino, o siano diagnosticate, con due o più neurotipi. La diagnosi è spesso tardiva e, dunque, potrebbe arrivare quando il lavoratore è già attivamente impegnato nel mondo del lavoro da anni.
Circa il 30% delle aziende Fortune 500 hanno avviato iniziative di assunzione neurodiverse (SAP, Microsoft, JPMorgan Chase, EY, ecc.).
Da dove si può iniziare?
Nel nostro contesto normativo la cornice di tutela correlata alle situazioni di neurodivergenza sembra, ancora, collegata unicamente al concetto di disabilità.
Il D.lgs. 62/2024 che ha recentemente riformato il sistema correlato alla inclusione delle persone con la disabilità, mette al centro la persona e i suoi obiettivi, introducendo una valutazione multidimensionale e il “Progetto di Vita”, volto a garantire inclusione e partecipazione nei vari ambiti (casa, scuola, lavoro, salute, tempo libero). La persona è soggetta dialogante nella definizione del progetto.
Le aspettative sono che sia l’accertamento che le conseguenti misure siano maggiormente orientati alle diverse dimensioni della diversità neurotipica e alla integrazione fra i possibili sostegni, fornendo anche uno strumento di più facile accesso, che aiuti a superare una persistente dimensione di marginalizzazione lavorativa, che parte fin dall’assunzione.
Secondo dati rilevati negli USA, il 76% dei candidati neurodivergenti trova i processi tradizionali (colloqui a tempo, assessment) penalizzanti.
Le considerazioni legali valgono, però, anche nei casi in cui il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione di disabilità, sebbene non certificata, in quanto ormai la giurisprudenza riconosce a suo carico le medesime obbligazioni che discenderebbero dalla presenza di una certificazione.
In termini più generali è necessario ricordare che il datore di lavoro ha degli obblighi di protezione, primi fra tutti quelli derivanti dall’art. 2087 c.c., che impongono di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori che, quindi, si affiancano alla dimensione sopra indicata.
In tale contesto i gruppi a rischio particolarmente sensibili devono essere protetti dai rischi che li riguardano specificamente e, pertanto, la valutazione dei rischi e l’adattamento dei luoghi di lavoro e procedure devono considerare le circostanze correlate alla neurodivergenza a prescindere dalla certificazione di una disabilità.
Quali domande occorre porsi?
È consigliato interrogarsi sulla portata delle proprie procedure interne e strumenti per capire se nascondano possibili rischi di discriminazione indiretta oppure insidie correlate alla corretta protezione della salute dei lavoratori.
Ad esempio, i sistemi di revisione delle prestazioni in termini tradizionali posso essere un ostacolo per talune tipologie di neurodivergenze: i motivi variano con la casistica, andando dalla difficoltà nell’autovalutazione all’importanza data a taluni aspetti sociali piuttosto che alla parte di competenza tecnica, alla prevalenza di aspetti quantitativi o alla formulazione di domande generiche.
Inoltre, c’è l’aspetto della sicurezza del lavoro.
Che cosa, dunque chiedersi:
- se le proprie procedure di sicurezza siano chiare e accessibili dal punto di vista linguistico
- se allarmi e avvisi siano stati valutati in ragione della necessità di raggiungere tutta la popolazione lavorativa con significato univoco
- se gli ambienti siano adeguati anche considerando l’incidenza del sovraccarico sensoriale (luci, rumore, numeri di persone) sull’effettiva possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa o se possono incidere sulla maggiore verificazione di eventi dannosi
- se caratteristiche specifiche (es. in alcuni casi la maggiore distraibilità) interferiscono sulla esecuzione di procedure e sulla elaborazione degli stimoli sensoriali; fattori che non sono di rischio per individui neurotipici possono esserlo per lavoratori neurodivergenti
- se gli strumenti informatici a disposizione necessitino di adattamenti (es. sintetizzatori vocali, programmi di pianificazione, doppi schermi per agevolare la concentrazione, software per le mappe mentali)
- se l’organizzazione del lavoro in termini di luoghi (lavoro in presenza o da remoto) e tempi sia adeguata e se le modifiche siano comunicate con modalità e tempistiche corrette anche per chi ha maggiore difficoltà di adattamento rispetto ai cambiamenti
- se si siano coinvolti adeguatamente i lavoratori interessati nei processi di valutazioni di tutti i punti sopra indicati.
E, soprattutto creare le condizioni ambientali e di politica interna per cui sia possibile una tempestiva adozione di adattamenti sul posto di lavoro, limitando non solo il rischio legale ma creando, per le società che l’hanno assunto come valore, i presupposti per l’inclusione.