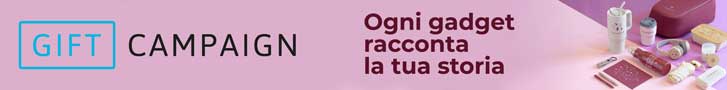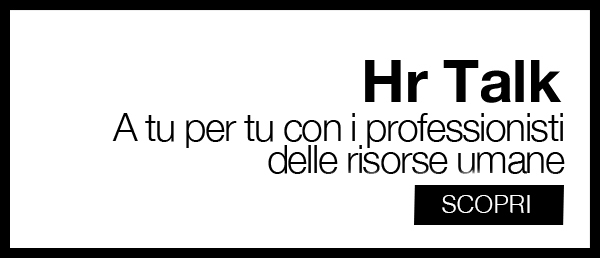Disabilità e lavoro: tante persone, tante competenze
Quali sono i doveri principali del datore di lavoro nell’inserimento e valorizzazione di lavoratori con disabilità? E il tema dei caregiver, l’altra faccia della medaglia.

In questa puntata della rubrica “Includere per Crescere” cerchiamo di fornire alcune chiavi di lettura sulla valorizzazione di un patrimonio di risorse e competenze oltre l’ottica dell’assolvimento degli obblighi di collocamento obbligatorio di persone con disabilità.
Qualche numero
Le persone con limitazioni nelle attività abitualmente svolte in Italia sono poco più di 12 milioni, ossia il 21,4% della popolazione, di cui il 5% con limitazioni gravi e il restante 16,4% con limitazioni non gravi.
Circa un terzo delle persone con disabilità in età lavorativa è occupato (il 12% di chi ha una limitazione grave, il 28,9% di coloro che hanno una limitazione non grave) e la maggior parte di questi lavoratori possono essere definiti a bassa intensità lavorativa. Lo svantaggio è ancora più netto per le lavoratrici.
Le persone con disabilità che hanno titoli di studio più elevati (diploma di scuola superiore e titoli accademici) è pari al 30,1% tra gli uomini e al 19,3% tra le donne, a fronte del 55,1% e 56,5% per il resto della popolazione; ciò è fortemente influenzato dai permanenti ostacoli alla piena inclusione scolastica, dovuti soprattutto a barriere architettoniche nelle scuole, carenza di insegnanti di sostegno e di strumenti tecnologici.
Nell’anno 2023/2024 nella scuola italiana si contavano 359 mila alunni con disabilità, circa il 4,5% del totale.
Si conta che in Italia ci siano 7 milioni di caregiver, di cui il 38% si prende cura di familiari non autosufficienti.
Definizione di disabilità e accomodamenti ragionevoli
Nell’attuale nozione (frutto della interpretazione delle corti europee), la condizione di disabilità è una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.
L’accomodamento ragionevole è necessario ogni qual volta l’applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l’effettivo e tempestivo esercizio dei diritti, su base di uguaglianza e consiste in misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.
Sulla scorta della nozione di disabilità, la giurisprudenza nazionale ha compiuto una profonda rivisitazione degli obblighi del datore di lavoro correlate alla disabilità, fino ad affermare che:
- è nullo il recesso per superamento del comporto calcolato senza tener conto dell’incidenza della disabilità, configurando una discriminazione indiretta nei confronti del prestatore in quanto la mancata considerazione dei rischi di maggiore morbilità dei lavoratori con disabilità trasmuta un criterio apparentemente neutro come il periodo di comporto in una prassi discriminatoria;
- l’accomodamento ragionevole è un insieme di misure appropriate, proporzionate e non sproporzionatamente onerose secondo la “comune valutazione sociale”, che un datore di lavoro deve adottare per garantire la piena partecipazione lavorativa del dipendente con disabilità;
- detti accomodamenti possono prevedere la modifica dei locali, l’adattamento delle attrezzature, dei ritmi lavorativi e della distribuzione dei compiti, l’adozione di lavoro da remoto e obblighi formativi supplementari;
- costituisce accomodamento ragionevole l’assegnazione a mansioni inferiori se non lesive della dignità e non eccessivamente onerose prima di procedere alla cessazione del rapporto di lavoro;
- il datore, che conosce o avrebbe potuto conoscere (con ordinaria diligenza) lo stato di disabilità del lavoratore, è obbligato ad agire sul piano organizzativo per adottare accomodamenti che evitino conseguenze discriminatorie;
- nelle predette situazioni, il datore di lavoro deve attivarsi per chiedere chiarimenti al dipendente e valutare accomodamenti idonei a evitarne il licenziamento. Il comportamento non collaborativo del lavoratore può eventualmente essere valutato nel contesto generale.
Il datore di lavoro dunque deve essere attivo, in buona fede, disposto a modificare la sua organizzazione e collaborativo.
Cosa devono fare gli HR?
I numeri ci dicono che la disabilità non è un fattore isolato. Riguarda tanti lavoratori e lavoratrici, tante e diverse famiglie.
Cosa devono fare gli HR (alla luce anche delle best practise)?
- valorizzare le competenze, non solo adempiere agli obblighi: l’inserimento di persone con disabilità non deve limitarsi al rispetto formale del collocamento mirato, ma puntare all’individuazione di ruoli utili per l’azienda e coerenti con le competenze reali della persona;
- negoziare accomodamenti ragionevoli fin dall’inizio: avviare un confronto già nella fase di assunzione per definire ambienti, strumenti, tecnologie e assetti organizzativi che abilitino la piena partecipazione del lavoratore, anziché ostacolarla;
- formare tutto il personale: spesso l’esclusione nasce dalla scarsa preparazione di colleghi e responsabili. È quindi essenziale includere la disabilità nei percorsi di formazione aziendale;
- affrontare il tema del linguaggio: il mancato o sbagliato uso di parole difficili costituisce uno degli elementi incidenti sulla non inclusività di un ambiente lavorativo e rappresenta anche un rischio legale nella gestione dei rapporti di lavoro;
- istituire una procedura per i casi di comporto
che tenga conto dei principi ormai consolidati nella giurisprudenza.
L’altra faccia della medaglia: i caregiver
In un paese che invecchia, la categoria dei caregiver riguarda 7 milioni di italiani, di cui il 56% in età compresa fra i 45 ed i 64 anni.
La Corte di Cassazione ha già affermato che il divieto di discriminazione non è limitato alle sole persone che siano esse stesse portatrici di disabilità, ma si estende anche a coloro che li assistono.
Con l’ordinanza interlocutoria n. 1788/2024, la Corte di Cassazione si è rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se al lavoratore caregiver vada riconosciuta la stessa tutela contro le discriminazioni indirette che spetta al disabile stesso se fosse lavoratore e se, in caso positivo, il datore di lavoro debba adottare soluzioni ragionevoli per assicurare la parità di trattamento del caregiver.
Il tema, dunque, è in continua evoluzione.
#Pittau #IncluderePerCrescere #Advant