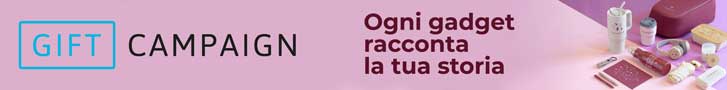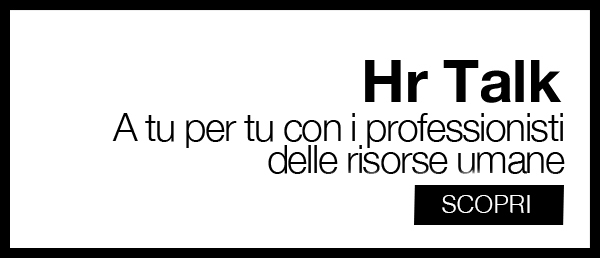Architetti di inclusione generazionale: una leva strategica per aziende intelligenti (e con spirito di adattamento)
Quanto ci piace etichettare! Essere parte di una coorte ci fa sentire sicuri e fieri: un gruppo che si connota per convinzioni che ci hanno accumunati per decenni.

È una fortissima rassicurazione ma, in realtà, produce l’effetto inevitabile del “noi e loro”, generando delle relazioni superficiali basate sulla prima evidenza e su vari bias, precludendo ogni forma di inclusività. Questo succede spesso anche tra le diverse generazioni presenti nelle aziende: quanto ci piace dire di appartenere all’una piuttosto che all’altra perché fieri delle caratteristiche che le connota! Sono addirittura puntualmente riportate dalla narrativa diffusa, orgogliosa di evidenziarne le differenze, che tanto più sono accentuate tanto più soddisfano i vari “creatori di contenuti”.
Il desiderio di appartenenza risulta pienamente appagato ma allo stesso tempo si commette l’errore di descrivere una rappresentazione rigida delle generazioni, come se fossero categorie statiche, ognuna chiusa nella propria bolla di caratteristiche immutabili. La realtà è ben diversa: persone e organizzazioni sono in continuo movimento, da sempre.
Da sempre, infatti, le organizzazioni sono composte da persone nate e vissute in contesti generazionali diversi che hanno costantemente convissuto e le aziende hanno continuato a funzionare e portare risultati. Quello che cambia, dunque, non sono le persone ma le differenti dinamiche sociali che si vivono nelle organizzazioni.
Per comprenderle davvero, serve uno sguardo evolutivo, capace di leggerne il cambiamento.
Partiamo dai dati: una buona prospettiva può essere quella di considerare un lasso temporale ampio. Prendiamo ad esempio gli ultimi 35 anni, così da abbracciare diverse generazioni nei contesti lavorativi, che in buona parte ancora sopravvivono nel tessuto aziendale italiano. Si osservano queste principali tendenze (fonti Istat e Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano):
- Spostamento dell’asse demografico dell’occupazione: oggi dominano Gen X e Millennials, mentre negli anni ’90 i Boomers costituivano il “core” della forza lavoro.
- Rallentamento dell’ingresso degli “under 35” per cui la leva giovanile è fortemente diminuita in % rispetto a trent’anni fa.
- Invecchiamento della forza lavoro: gli over 50 sono sempre più numerosi oggi rispetto al passato.
- I Boomers che nel 1990 costituivano il core di ogni azienda sfiorando il 55%, oggi non hanno le stesse prospettive di pensione a breve come i loro ex capi della “Generazione Silenziosa”, ma ci vorrà circa almeno un decennio anni per raggiungere il traguardo
- Negli anni ’90 la Generazione Silenziosa, che costituiva circa il 20% della forza lavoro, era in procinto di andare beatamente in pensione, favorendo un ricambio generazionale nelle organizzazioni (nuova linfa)
- L’ingresso da qualche anno nel mondo del lavoro della generazione fortemente digitale dei Gen Z: sono quelli che la trasformazione digitale non l’hanno subita bensì, semplicemente, la vivono.
È evidente quando la forza lavoro italiana sia cambiata radicalmente tra il 1990 e il 2025. Un tempo dominavano i Boomers, mentre oggi sono la Generazione X e i Millennials a fare la parte del leone. I giovani (under 35) hanno subito un significativo calo in percentuale (da un 25% ad un 15% scarso) mentre gli over 50 oggi sono una componente sempre più rilevante: entro il 2040, in Italia andranno in pensione circa 3 milioni di lavoratori attualmente attivi, appartenenti in gran parte alle generazioni dei Baby Boomer e della X.
Importante considerare anche che la disponibilità dei giovani diventa sempre minore: secondo il rapporto Giovani 2024: bilancio di una Generazione, negli ultimi vent’anni il nostro Paese ha perso oltre un quinto degli under 35, molti dei quali hanno scelto di cercare migliori opportunità all’estero. Il 18° Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes racconta un trend preoccupante: nel solo 2022, il 44% degli italiani emigrati aveva tra i 18 e i 34 anni, un dato in crescita rispetto agli anni precedenti. Tra il 2011 e il 2023, quasi 550.000 giovani italiani in questa fascia d’età hanno lasciato il Paese.
Parallelamente, l’ISTAT ci segnala che la popolazione italiana calerà dagli attuali 59 milioni a circa 54 milioni nel 2050, con una quota di over 65 che supererà il 35%. In questo scenario, pensare a una “sostituzione” generazionale totale sembra irrealistico. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale e l’automazione di molti processi, presumibilmente, non sarà nemmeno più una necessità.
Quello che diventa cruciale è, invece, un cambio di prospettiva.
Dobbiamo imparare ad accelerare l’integrazione e la valorizzazione delle competenze e delle esperienze di tutte le generazioni presenti nelle aziende, senza fossilizzarci su ricorrenti stereotipi quali “noi e loro” e “la nostra generazione è la migliore”. È inevitabile che conviveranno più a lungo diverse generazioni negli stessi spazi professionali ed è proprio a partire da questa convivenza che dobbiamo trarre una nuova risorsa, sia per una sostenibilità aziendale sia per la sopravvivenza lavorativa di ogni persona.
Infatti, trent’anni fa le dinamiche socio – organizzative erano più semplici rispetto ad oggi: i “silenti”, in veloce avvicinamento alla pensione, lasciavano alla generazione dei Boomers lo scettro della guida che avrebbero usato per inglobare la GenX. Quest’ultima ha assimilato, infatti, i loro valori a loro volta ereditati e ulteriormente sviluppati. Il tutto in un assunto di base, quello dell’“azienda mamma protettrice”.
Da allora se ne è fatta di strada, molto spesso fortemente accidentata, con crisi globali profonde che hanno portato le aziende a pesanti ristrutturazioni: la “mamma” non c’è più, così come il mito della “stessa azienda per sempre”. Dal momento che questa era la situazione, allora ogni persona ha dovuto fare i conti con il proprio sé adulto, aumentando l’istinto di sopravvivenza: la capacità di mantenere quanto più possibile la propria occupabilità, l’agilità di cambiare lavoro in aziende diverse nella speranza di trovare situazioni migliori sia in termini economici che di prospettive di sviluppo personale.
Pensiamoci bene: tutto ciò non accade ad una generazione piuttosto che ad un’altra. Accade ad ogni singola persona. L’età incide di fatto e principalmente nel determinare la singola esigenza e gli specifici desideri da soddisfare. Sopravvivere nel breve, medio o lungo termine è la spinta ad azioni diverse, ma sempre di sopravvivenza si tratta.
Le organizzazioni, allora, dovrebbero cominciare a investire seriamente in programmi di inclusione generazionale. Nel senso di ascoltare quelle che sono le esigenze della singola persona, consapevoli che possono essere diverse, alla ricerca di una propria sostenibilità nel tempo, dal punto di vista di una “forza lavoro” eterogenea, cercando al loro interno un equilibrio di linguaggio e valori comuni.
In questo senso, “inclusività generazionale” significa far coesistere interessi e desideri personali che possono essere differenti in base all’età e alla seniority lavorativa svincolandosi dal concetto di appartenenza ad un “cluster” predefinito ed etichettato di “Boomer”, “X”, “Millenials” o “GenZ”. Il tutto è reso anche più complesso dal fatto che nelle realtà aziendali italiane, di “Silenti” ce ne sono ancora, eccome, spesso alla guida di aziende solide, costituendo una forte e diffusa élite di comando gerontocratica.
È essenziale, quindi, costruire un linguaggio comune, che faciliti il dialogo e la comprensione reciproca, per ottenere come risultato una maggiore sostenibilità organizzativa e la continuità dei risultati di business, in un contesto demografico sfidante. Per le aziende, è importante trovare una modalità di comprensione, costruire nuove relazioni forti con le persone di ogni generazione e avere un dialogo costruttivo con un lessico comune e comprensibile per una efficace condivisione di interessi e intenti reciproci.
Un buon punto di partenza, potrebbero essere le competenze, un evergreen sempre valido, solo qualche volta superato dall’interesse al potenziale esprimibile delle persone. Credo che oggi le competenze siano più utili come leva di inclusività: c’è chi le può trasferire e c’è chi le deve apprendere, non potendo continuare a vivere di sola potenzialità da esprime chissà quando e chissà in quali contesti.
In questo senso, si sono avuti dei buoni esempi recentemente:
- Enel: programmi di reverse mentoring per accelerare la digitalizzazione e favorire dialogo tra generazioni.
- Luxottica: team multigenerazionali in progetti strategici, con enfasi su mix di competenze tra senior e giovani
La Funzione HR non sbaglierebbe se raccomandasse all’AD o direttamente agli azionisti di molte PMI delle attività legate a:
- Mentoring e reverse mentoring: scambio di competenze tra senior e junior.
- Gruppi intergenerazionali su progetti concreti per favorire dialogo e apprendimento.
- Formazione personalizzata secondo stili e preferenze di apprendimento (c’è chi predilige l’online e chi la presenza fisica, chi il sincrono e chi l’asincrono)
Più se ne avranno, più si stimolerà uno stile di leadership diffusa nell’organizzazione, inclusiva e basata sull’ascolto attivo, che valorizza la voce e il contributo di tutte le età!
La leadership dovrebbe focalizzarsi su tematiche quali:
- Eliminare stereotipi e malintesi.
- Costruire stili comunicativi divergenti compresenti: formale vs diretto.
- Approccio al lavoro: presenza fisica vs lavoro da remoto.
- Superare il pregiudizio che il digitale sia divisivo delle generazioni
- Migliorare il clima aziendale, portando benessere: si potrà stare bene in azienda perché sia gli spazi fisici saranno più piacevoli, sia perché le policy saranno basate su principi di convivenza sana e non di regole e norme scritte sulla pietra
- Aumentare il desiderio di appartenenza attraverso delle semplici regole di ingaggio e motivazione basate sul “dare senso a ciò che si fa”, perché piacerebbe a tutti, indipendentemente dall’età, essere informati del “purpose” aziendale attraverso una comunicazione capillare, efficace e comprensibile
Quindi, puntualizzare le differenze generazionali è meno proficuo rispetto a lavorare su quanto le persone nate in generazioni diverse possano portare della loro esperienza, competenza, valori e interessi personali. Le aziende che costruiscono ponti tra le persone con età differenti saranno in grado così di trattenere quelle di talento (non sono solo “i giovani talenti” quelli di cui si ha bisogno), innovare continuamente prodotti e approccio ai clienti e migliorare la possibilità di dare opportunità a tutti per il proprio fine: quello di sostenere i risultati nel tempo con una ricchezza organizzativa fondata sulle persone, di ogni età.
I dati confermano che le realtà aziendali che sanno valorizzare le differenze generazionali prosperano. Secondo il report McKinsey (2024), infatti, le aziende con diversità generazionale attiva registrano performance finanziarie superiori del 25% rispetto alla media.
Secondo Deloitte (2023), oltre il 70% dei leader HR considera la diversità generazionale strategica (anche se solo il 15% ha implementato programmi dedicati!).
Direi che sia molto importante se non indispensabile iniziare ad attivarsi velocemente, strappando le etichette che ci bloccano e non ci permettono di progredire.