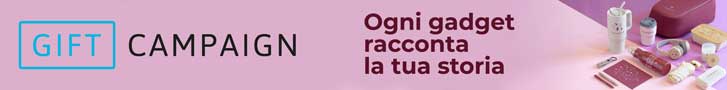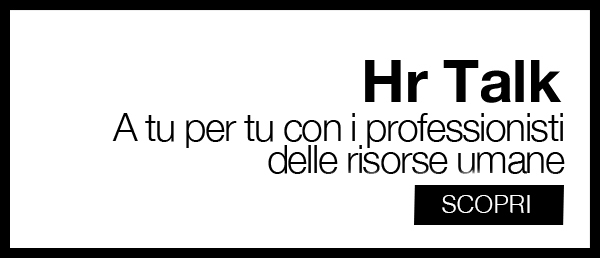Verso un’adozione consapevole dell’AI: il fattore human prima della tecnologia
L’adozione dell’intelligenza artificiale cresce rapidamente, ma la vera sfida resta umana: è con cultura digitale, formazione e leadership che la tecnologia si trasforma in valore, e l’HR diventa il motore del cambiamento verso un’AI consapevole, etica e condivisa

L’intelligenza artificiale non è più una curiosità riservata alle specializzazioni universitarie o ai giganti dell’innovazione: con una crescita del 58% in un solo anno, nel 2024 il mercato italiano è salito a 1,2 miliardi di euro, e quasi sei grandi aziende su dieci dichiarano di avere già un progetto di AI attivo, mentre il 99% delle persone ha sentito parlare di intelligenza artificiale.
Quando l’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano ha mappato le soluzioni presenti nei dipartimenti risorse umane, ha scoperto che il 32% delle imprese italiane utilizza almeno una tecnologia AI per gestire i candidati o per supportare i propri dipendenti, con applicazioni che spaziano dai chatbot conversazionali, all’analisi semantica per selezionare i curricula, fino alla personalizzazione dei percorsi di formazione e al matching dei profili più rispondenti a una ricerca.
Dati in crescita, ma manca consapevolezza
L’ecosistema degli HR analytics, già in forte movimento da molto prima dell’arrivo della Generative AI, cresce e incoraggia funzioni come recruiting, formazione, performance management ed engagement a orientarsi sui dati e a collaborare con colleghi esperti di tecnologia per raffinare le funzionalità.
Ma la vera sfida non riguarda tanto la maturità dei modelli, quanto la preparazione delle persone chiamate a governarli. Una recente ricerca di Gallup evidenzia che sette lavoratori su dieci non usano mai l’AI, mentre solo uno su dieci la utilizza settimanalmente, e appena il 15% degli intervistati ritiene che l’organizzazione abbia comunicato una strategia chiara sull’AI.
La distanza tra aspettative e realtà è fotografata anche dal rapporto Superagency in the workplace di McKinsey, che riporta come il 92% delle aziende mondiali prevede di aumentare gli investimenti in AI generativa nei prossimi tre anni, ma solo l’1% dichiara di avere una gestione matura della tecnologia.
Ancora prevale la shadow AI o la BYOAI (bring your own AI), in cui i dipendenti utilizzano strumenti selezionati personalmente tre volte più spesso di quanto pensino i manager, e quasi metà di loro impiega l’AI generativa per almeno il 30% del proprio lavoro.
E sono gli stessi lavoratori a chiedere maggiore formazione: quasi uno su due indica che un programma di training strutturato sarebbe la leva principale per massimizzare i benefici, mentre un lavoratore su cinque lamenta di aver ricevuto poco o nessun supporto, affidandosi prevalentemente ad autoformazione.
La mancanza di visione strategica porta molte aziende a fermarsi ai progetti pilota, e non a caso solo l’11% dei dipendenti si sente preparato a collaborare con l’A. Anche i dati dell’Anthropic Observatory confermano una corsa veloce, ma disomogenea: in poco più di due anni la quota di lavoratori americani che utilizzano l’AI è raddoppiata dal 20% al 40%, e nelle grandi aziende il 77% dell’utilizzo riguarda l’automazione completa di task. Insomma, la si usa, ma spesso in modo disorganizzato e inconsapevole, affidandosi al buon senso e all’autoformazione più che allo studio.
Formazione e cultura digitale come leve per l’adozione
Dando uno sguardo all’Italia, l’adoption si presenta molto segmentata: per ISTAT nel 2024 la percentuale di aziende con almeno dieci dipendenti che impiegano l’AI è passata dal 5% all’8,2% in un anno. La crescita è più marcata nelle organizzazioni con 50-99 addetti (dal 5,3% al 14%) e tra le grandi (dal 24,1% al 32,5%). Gli utilizzi più diffusi sono la generazione di conoscenza dai dati (54,5%), l’AI generativa (45,3%) e l’automazione dei flussi di lavoro (28,1%).
Sorprende che il 38,1% delle imprese consideri la formazione del personale interno l’elemento decisivo per il successo dei progetti (una percentuale che sale al 70,8% fra le grandi aziende), mentre il 22% sottolinea la necessità di assumere talenti con competenze AI. Quasi un’azienda su tre indica la carenza di competenze (tecniche, ma anche trasversali) come principale ostacolo, e il 26% reclama percorsi formativi specifici per ruolo.
La dimensione generazionale pesa: il 62% dei lavoratori italiani utilizza l’AI al lavoro e la percentuale sale all’89% tra i Gen Z mentre il 64% dei baby boomer non la usa mai, resta chiaro che l’entusiasmo dei più giovani si accompagna a un’adozione molto legata alla produttività personale, spesso a compiti come traduzione di testi, correzione grammaticale o riformulazione di contenuti e nell’85% dei casi genera un aumento della produttività percepita.
Il 68% dei lavoratori italiani ha già sperimentato la Generative AI, ma il 36% teme di essere sostituito, e soprattutto solo un quarto degli operatori si sente supportato ritenendo di avere ricevuto una adeguata formazione. Il 37% degli intervistati dichiara che la carenza di strumenti e la mancanza di appoggio da parte del management spingono più della metà dei dipendenti a ricorrere a strumenti di shadow AI non autorizzati.
Il sostegno della leadership fa la differenza: quando i dirigenti promuovono l’uso dell’AI, l’ottimismo sul futuro professionale cresce di quaranta punti. Ecco perché l’adozione non è un automatismo tecnologico, ma un percorso di cambiamento culturale che ha bisogno di strategia e di consapevolezza nel comprendere i punti di partenza interni, soprattutto quelli derivanti dalla varietà generazionale. È fuorviante e inefficiente pensare di utilizzare gli stessi identici percorsi di formazione per persone di classi anagrafiche profondamente diverse.
Il panorama italiano tra sviluppo dell’AI e gap di competenze
Nello scenario appena descritto il ruolo delle risorse umane è fondamentale. L’HR deve essere al centro della trasformazione, perché conosce i processi, misura l’impatto sull’organizzazione e deve creare una cultura che valorizzi e integri le tecnologie. Numerose ricerche mostrano che l’analisi dei dati può migliorare la qualità del recruiting, personalizzare la formazione, rendere più equa la valutazione delle prestazioni e stimolare l’engagement, ma questo è possibile solo se l’HR è adeguatamente preparato con competenze analitiche e se instaura un dialogo costante con i reparti IT e legali per garantire che l’uso dei dati rispetti le normative e non produca discriminazioni.
Inoltre, la normativa dell’AI Act richiede che le imprese investano nell’alfabetizzazione dei dipendenti all’AI e che vigilino sui sistemi adottati internamente, in particolare su quelli HR molti dei quali classificati ad alto rischio. L’adozione dell’AI non può essere lasciata alle iniziative spontanee, ma deve seguire percorsi strutturati e coerenti con la strategia aziendale e le prescrizioni normative. Un buon numero di ricerche evidenzia come le aree in cui si concentrano gli investimenti sono principalmente la formazione e lo sviluppo (22%), l’engagement (20%), performance management e recruitment (18%). Non mancano le preoccupazioni: circa un terzo dei responsabili HR teme di perdere la componente umana dei processi, e uno su tre denuncia poca conoscenza della materia, mentre un altro terzo solleva dubbi etici.
Il ruolo strategico delle Risorse Umane
Di fronte a queste evidenze, il compito delle risorse umane non è quello di rincorrere l’ultima piattaforma, ma di orchestrare un cambiamento che metta le persone realmente al centro. E non è un facile slogan, ma un tema di sostanza che mette in discussione la buona riuscita di un percorso di adoption. Da un lato occorre creare una cultura del dato, mappare i processi e capire dove l’AI può generare valore liberando le persone da attività ripetitive e supportando la creatività e la capacità decisionale.
Dall’altro è necessario costruire percorsi di upskilling e reskilling che aiutino i collaboratori a leggere i dati, interpretare le risposte degli algoritmi, integrarne i suggerimenti nel proprio giudizio e sviluppare soft skill come problem solving, creatività, comunicazione e leadership. Soprattutto in un momento in cui il dibattito è polarizzato sull’alternativa augmentation vs automation, bisogna tenere la guardia alta sul possibile rischio del deskilling.
Numerosi studi ci dicono che l’esposizione continua all’AI può indebolire le abilità. Ed è qui che l’HR sarà sempre più chiamato a vigilare. La formazione deve essere personalizzata, capace di colmare le differenze generazionali che emergono nelle organizzazioni, e soprattutto deve essere accompagnata da una comunicazione trasparente. I dipendenti che percepiscono una strategia chiara sono quasi tre volte più propensi a sentirsi preparati e a proprio agio nell’uso dell’AI. Ecco allora che l’HR può diventare il punto di riferimento per costruire questa narrativa, definire policy d’uso, organizzare percorsi di apprendimento, sensibilizzare sui rischi e sulle opportunità, e dialogare con i diversi portatori di interesse esterni per promuovere un’evoluzione responsabile.
Le persone al centro della trasformazione
Se la tecnologia corre, l’elemento determinante rimarrà la capacità di coinvolgere e far crescere le persone. La promessa di un futuro in cui l’AI si occupa della routine per lasciare spazio alla strategia, all’empatia e all’innovazione sarà possibile solo se le aziende investiranno prima di tutto nel capitale umano. Il successo dell’AI richiede un approccio sistemico in cui gli HR siano artefici e custodi del cambiamento, pronti a intrecciare competenze tecnologiche e sensibilità umanistiche, costruire culture della fiducia e della sperimentazione e misurare risultati non solo in termini di efficienza, ma di crescita e benessere collettivi.
L’impostazione che proponiamo come Glasford è quella di trasformare l’AI da “oggetto tecnologico” a pratica organizzativa, partendo proprio dalle persone. Il punto di attacco è comprendere la readiness e le priorità, così da evitare progetti “tech–first” e abilitare una vera adozione consapevole: è questo l’obiettivo del DAI – Diagnostic Artificial Intelligence, uno strumento che combina una fotografia quantitativa (AI Compass) e una validazione qualitativa (Deep Dive) per far emergere forze, gap e rischi lungo le dimensioni di strategia, governance, competenze e processi.
L’AI Compass restituisce una prima fotografia dell’organizzazione e segnala la necessità di alfabetizzazione prima di qualsiasi rollout; questo consente al management di decidere con evidenza dove intervenire prioritariamente, se su leadership e change, su data foundation o su risk & compliance.
In parallelo, le Deep Dive Interview con gli stakeholder mappano organizzazione, meccanismi di supervisione, chiarezza decisionale, ruoli/responsabilità e preparazione ai requisiti di conformità: insight utili per impostare un piano d’azione che tocchi davvero i nodi che fanno la differenza sui risultati. Questa metodologia, che integra misurazione e ascolto, risponde esattamente al bisogno di agire sulla componente human per passare dal trend alla performance, colmando il divario tra potenzialità dei modelli e capacità delle persone di guidarli.
Dalla diagnosi alla consapevolezza: il metodo Glasford
Dalla diagnosi alla crescita delle competenze, Glasford accompagna quindi board, executive, manager e team operativi con i percorsi AI Discovery Journey e AI Development Program. Si tratta di moduli di literacy e di approfondimento su fondamentali, digital mindset, profili legali/compliance e applicazioni business, configurabili per destinatari e tempistiche diversi.
L’approccio è learning-by-doing e orientato ai casi d’uso delle funzioni, per costruire linee guida d’impiego, policy d’uso responsabile e metriche di valore che definiscano meglio l’uso dell’AI in azienda e la variabilità di adozione. Il punto centrale su cui insistiamo nei nostri progetti è proprio quello di riuscire ad abilitare le persone a saper porre le giuste domande, perché non è la tecnologia a mancare, ma in molti casi la capacità delle persone di comprenderla e di guidare efficacemente il cambiamento. È a questo livello che Glasford è l’advisor migliore per le organizzazioni, facendo in modo che l’intervento tecnologico non sia un obiettivo in sé, ma una componente di innovazione che deve essere necessariamente armonizzato con la parte human.
I percorsi per sviluppare competenze AI
Advisory, formazione, consulenza, ma non solo. Nella parte di esecuzione, Glasford integra le storiche practice di Executive Search, Assessment Architecture e Talent Strategy per presidiare al meglio i ruoli critici (CxAI, data/ML lead, CIO / CTO) e l’architettura delle competenze, così che la governance dell’AI cresca insieme alla capacità di esecuzione quotidiana, mettendo in sicurezza i piani di investimento e i processi di integrazione.
In questo senso è cruciale anche la capacità di leggere il fattore generazionale nelle meccaniche di adoption per poter valorizzare al meglio le diverse posizioni che le persone hanno nei confronti della tecnologia, traendo il meglio da ciascun punto di vista e dalle esperienze di ognuno.
È anche questo il senso dei percorsi di reverse mentoring che Glasford ha sviluppato, affiancando a responsabili aziendali giovani neolaureati in funzione di mentor, così da migrare reciprocamente la conoscenza dell’AI con la conoscenza dei processi interni all’azienda. È questo l’approccio integrato tra HR e processi con cui misuriamo dove l’organizzazione si trova rispetto alla tecnologia, allineiamo leadership e processi, sviluppiamo competenze mirate perché l’AI diventi un mindset organizzativo, e non un’iniziativa isolata. E in questo approccio la centralità dell’HR è uno dei cardini della buona riuscita di un’efficace AI adoption, fattore fondamentale per assicurare che le strategie di innovazione dell’organizzazione possano raggiungere pienamente gli obiettivi con lungimiranza e solidità.