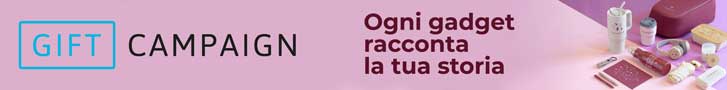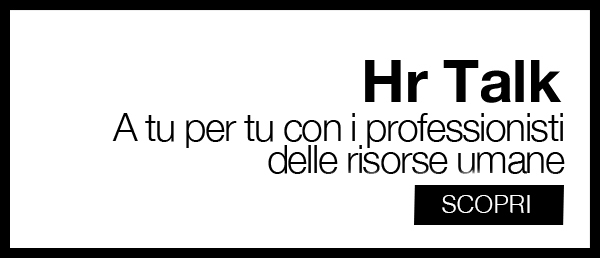Coinvolgere per crescere: strumenti e prospettive per la partecipazione dei lavoratori nelle aziende
La partecipazione dei lavoratori apre nuove prospettive per imprese più eque e collaborative: a spiegarlo è Roberto Ferrari, Responsabile HR Solutions e Direttore del Master HR ISMO

La partecipazione dei lavoratori nelle aziende sta diventando una leva strategica per le imprese. Coinvolgere attivamente le persone significa valorizzare competenze, migliorare il clima aziendale e creare spazi di collaborazione reale. Dalle commissioni paritetiche ai gruppi di lavoro interfunzionali, i modelli già in campo mostrano come il contributo dei lavoratori possa incidere su processi, performance e relazioni.
Ne abbiamo parlato con Roberto Ferrari, Responsabile dell’Area HR Solutions ISMO e Direttore del Master HR ISMO giunto alla 32esima edizione, per capire quali strumenti e prospettive stanno prendendo forma nelle organizzazioni.
Perché la partecipazione nei luoghi di lavoro è importante?
“La partecipazione è davvero per tutti: non distingue per fascia d’età, reddito o ruolo all’interno delle organizzazioni.
I padri costituenti avevano scritto l’articolo 46 della Costituzione italiana, che valorizza il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese, chiamato allora “collaborazione”. Nel 1948 questa impostazione non era certo rivoluzionaria: nella ricostruzione ciò che contava era decidere, fare, operare, quindi forse era difficile far partecipare. È un salto importante rispetto all’idea che il lavoratore fosse un numero o che fosse spaesato all’interno delle imprese”.
Quali strumenti e modelli consentono la partecipazione?
“Alcuni contratti collettivi, come quello dei metalmeccanici, riconoscono l’importanza dei meccanismi partecipativi. Tra questi ci sono le commissioni paritetico-bilaterali: gruppi che non decidono, ma si consultano, analizzano e approfondiscono aspetti della vita organizzativa — formazione, inquadramento, sicurezza e altri processi aziendali.
La diversità di opinioni, anche discordanti, amplia il quadro di analisi, e ciò è una premessa al lavoro in gruppo, che cerca di convergere verso decisioni condivise.
Sul piano legislativo, due momenti hanno accelerato la partecipazione: il decreto legge del 24 aprile 2017, che prevedeva una decontribuzione parziale per le imprese che sperimentavano meccanismi partecipativi, e la legge del 2025, che apre alla partecipazione “istituzionale o gestionale”, seguendo modelli europei di co-gestione, ma conferma l’utilità della partecipazione economica, finanziaria e organizzativa.
È interessante passare da una gestione aziendale basata sull’autorità e sulla leadership forte a un approccio che, oltre all’aspetto gerarchico-funzionale — che rimane per definire obiettivi, assegnarli e controllarli — preveda anche il coinvolgimento delle persone. Questo contribuisce a migliorare il clima aziendale e, presumibilmente, anche performance e produttività.
Accanto alla normativa, ci sono valori come ESG e Corporate Social Responsibility, che rafforzano collaborazione, coinvolgimento e responsabilità sociale d’impresa. Collegare partecipazione e responsabilità sociale è importante: un management che costruisce un clima sereno e collaborativo può orientare selezione e valorizzazione delle persone su criteri equi, inclusivi, diversi una gestione basata su simpatie personali. In questo contesto il ruolo delle parti sociali rappresenta una potenzialità di indirizzo e di suggerimento: Confindustria, CGIL, CISL e UIL dovrebbero essere alfieri della partecipazione nelle imprese”.
Con ISMO avete organizzato e seguito la gestione di gruppi partecipativi: come funzionano?
“Negli ultimi 6–7 anni abbiamo gestito circa un centinaio di gruppi di lavoro, generalmente composti da 6 a 12 persone, interfunzionali e con metà dei membri nominati dalla direzione aziendale e metà dalle organizzazioni sindacali.
Il percorso tipico prevede:
- Day One: una giornata di formazione iniziale, da tre fino a otto ore, con il supporto di un trainer ISMO e di un assistente ISMO che aiuta a definire il piano di lavoro.
- Incontri successivi: cinque, sei, otto o dieci sessioni, la durata e la frequenza dipendono dall’azienda e dal budget.
- Day Two: mezza giornata di presentazione dei risultati, con scambio tra i gruppi e discussione delle proposte, anche con la Direzione aziendale.
Le aziende possono ripetere l’esperienza più volte, ma si consiglia sempre di partire con un progetto pilota e di costituire un Comitato Guida, composto da rappresentanti sindacali e datoriali, per monitorare l’esperienza e affrontare eventuali criticità.
Il nostro ruolo, il “terzo metodologico”, è fondamentale: non entriamo nel merito tecnico, ma forniamo strumenti, formazione e metodo per far emergere le idee di tutti. Questo è cruciale perché i gruppi spesso contengono persone con stili comunicativi diversi: chi è più timido deve poter intervenire, chi è più loquace non deve monopolizzare la discussione”.
Quali sono i benefici concreti della partecipazione?
“La partecipazione genera valore tangibile: per i gruppi che abbiamo seguito gli obiettivi toccavano tematiche relative all’aumento della produttività, riduzione dei near miss, costi della non qualità, miglioramento della gestione delle scorte e della logistica, aumento della collaborazione e del sostegno reciproco e, ovviamente, miglioramento della comunicazione, del clima aziendale e degli spazi comuni.
Chi lavora direttamente sui processi conosce vincoli e criticità; il suo coinvolgimento nei gruppi permette di trovare soluzioni più efficaci rispetto a ipotesi esterne. Le idee non hanno gerarchia: contano la qualità e la concretezza dei suggerimenti.
Anche il coinvolgimento attivo nelle decisioni, attraverso co-gestione, partecipazione economica o finanziaria, rende i lavoratori protagonisti della vita dell’impresa, andando oltre il ruolo operativo e favorendo inclusione e equità. Il vero cuore della partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa resta però la loro presenza attiva in comitati e gruppi di lavoro”.
Quali sono le sfide e le prospettive future per la partecipazione in Italia?
“I progetti partecipativi in Italia sono ancora pochi. Spesso le grandi aziende coinvolgono poche decine di persone su migliaia di dipendenti, e la partecipazione rischia di restare burocratica: avere un gruppo di lavoro senza ascolto reale non ha senso.
Siamo ancora ai primi passi: la soluzione passa da esperienze pilota, comitati di guida condivisi e un ruolo attivo del terzo metodologico.
In prospettiva, è importante ampliare il numero di imprese e enti pubblici che adottano meccanismi partecipativi. La partecipazione non è solo legge o contratto: è un processo motivazionale e psicosociale, basato su ascolto, dialogo, empatia e capacità di collaborare. La dimensione umana resta il vero cuore dell’esperienza partecipativa: serve la capacità delle persone di collaborare, ascoltare e mettersi nei panni degli altri”.