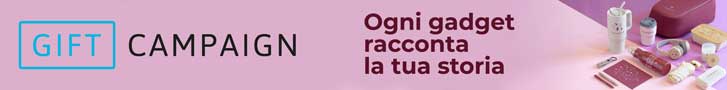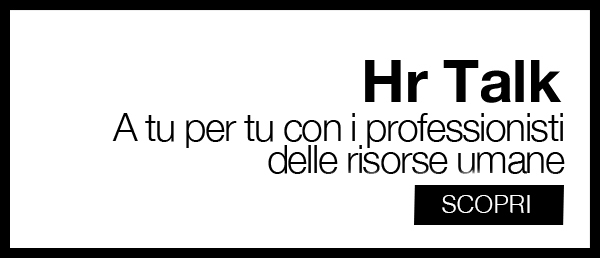Dal modello imprenditoriale alla struttura manageriale: qual è il ruolo dell’HR (e non solo)?
L’HR è la figura-chiave nel processo di passaggio da una gestione imprenditoriale a una manageriale più organizzata. Evidenziamo luci e ombre di una trasformazione delicata quanto (spesso) fondamentale con Gianluca Morosini, Head HR di B.Kolormakeup & Skincare Spa

Quando un’azienda passa da una guida fondata sull’imprenditore a una gestione strutturata, cambiano governance, processi e cultura interna. In questo scenario, la funzione HR gioca un ruolo chiave nel sostenere la transizione, rafforzare la leadership diffusa, comunicare e accompagnare il cambiamento organizzativo, con l’ausilio di strumenti efficaci e leve strategiche.
Ne abbiamo parlato con Gianluca Morosini, Head HR di B.Kolormakeup & Skincare Spa, che ha messo in luce – anche ma non solo – come l’HR debba dotarsi di una cassetta degli attrezzi con competenze specifiche, tra le quali primeggia la leadership di influenza.
Partiamo dall’inizio: quali sono, dal suo punto di vista, i segnali più evidenti che indicano che un’azienda è pronta per passare da una gestione imprenditoriale a una struttura manageriale più organizzata?
Penso che riconoscere questi segnali non è mai immediato. È un processo che richiede l’occhio esperto di chi ha attraversato realtà così diverse da aver vissuto questa trasformazione in prima persona. Sintetizzando, a mio parere, i segnali più evidenti sono tre.
Il primo è quello che io definisco il collo di bottiglia decisionale: l’imprenditore, che fino a ieri riusciva a tenere tutto sotto controllo, improvvisamente si trova sommerso da decisioni che prima era in grado di prendere in tempo reale. Questa situazione diventa insostenibile quando i numeri crescono; non è più possibile che una sola persona, per quanto brillante, riesca a mantenere il polso di tutto ed è necessario intraprendere un percorso di trasformazione manageriale.
Il secondo indicatore fondamentale è la perdita di efficacia nei processi operativi. Il successo di un’organizzazione dipende proprio dalla capacità di creare meccanismi di controllo e coordinamento che non passino necessariamente dalla direzione centrale per ogni singola decisione. L’imprenditore che si accorge di non riuscire più a garantire la qualità del servizio o del prodotto perché non riesce fisicamente a supervisionare tutto, sta vedendo il primo vero campanello d’allarme.
Il terzo segnale, spesso sottovalutato o sminuito dall’imprenditore, è il momento in cui le dinamiche informali non bastano più a garantire l’armonia organizzativa. Quando le tensioni iniziano a emergere non più come episodi isolati, ma come pattern sistematici, significa che la crescita ha superato la capacità della struttura informale di autoregolarsi; in questi momenti serve una struttura manageriale e una strategia HR capace di gestire complessità umane che vanno oltre la relazione diretta imprenditore-dipendente.
Una transizione di questo tipo non riguarda solo i processi, ma tocca profondamente anche la cultura aziendale. Quali sono le sfide più complesse che si affrontano in questo passaggio?
La sfida più complessa che ho sempre riscontrato è quella che chiamerei la paura della perdita di identità.. I collaboratori storici, quelli che hanno contribuito a costruire il successo dell’azienda, spesso vivono questa transizione come un tradimento dei valori fondativi. È comprensibile: hanno sempre avuto un rapporto diretto con l’imprenditore, si sono sentiti parte di una famiglia piuttosto che di un’organizzazione, e ora vedono arrivare processi, procedure, livelli gerarchici che sembrano spersonalizzare quello che prima era molto umano.
Un’altra dimensione critica è quella che definirei la resistenza dei middle manager improvvisati. In molte realtà imprenditoriali, ruoli di coordinamento nascono per necessità operative, non per pianificazione strategica. Persone capaci e competenti tecnicamente si trovano improvvisamente a gestire team senza avere mai ricevuto formazione manageriale: è necessario in queste fasi accompagnare queste persone nella transizione, trasformando manager “per caso” in leader consapevoli.
Ma forse la sfida più sottile è quella culturale legata al rapporto con l’errore e con il rischio. L’imprenditore, per natura, è abituato a decidere velocemente, anche con informazioni incomplete, accettando il rischio come parte del gioco. Una struttura manageriale, invece, tende per natura alla prudenza, alla raccolta di dati, all’analisi approfondita. Trovare il giusto equilibrio significa creare una cultura che mantenga la propensione al rischio calcolato tipica dell’imprenditoria, ma con la solidità procedurale necessaria per gestire la complessità.
Il ruolo della funzione HR in questo scenario è tutt’altro che secondario. Come si può accompagnare il cambiamento organizzativo senza snaturare lo spirito imprenditoriale che ha portato l’azienda fin lì?
Non si tratta semplicemente di introdurre processi, si tratta di farlo in modo tale che questi processi diventino abilitatori della creatività e dell’agilità, non ostacoli. Dalla mia esperienza, il primo elemento fondamentale è quello che chiamerei la velocità decisionale selettiva. Non tutto richiede lo stesso livello di strutturazione.
L’esperienza mi ha insegnato che esistono decisioni che possono e devono rimanere veloci e informali, e altre che invece richiedono un processo più articolato. L’arte sta nel saper distinguere le une dalle altre e nel creare meccanismi che rispettino questa distinzione.
Prendiamo l’esempio della selezione del personale. In una multinazionale strutturata, come per esempio Amazon, è inevitabile seguire processi standardizzati a livello globale. In una realtà come B.Kolor, invece, possiamo permetterci di mantenere un approccio più personale e diretto, pur introducendo strumenti di valutazione che garantiscano qualità e oggettività. Non si tratta di scegliere tra struttura e agilità, ma di trovare il giusto mix per ogni situazione.
Un altro aspetto fondamentale è quello che definirei la meritocrazia trasparente. L’imprenditore spesso premia l’iniziativa, la creatività, la capacità di risolvere problemi, anche quando questi comportamenti non seguono canali formali. L’HR deve trovare il modo di riconoscere e premiare questi stessi comportamenti, ma attraverso meccanismi più strutturati e trasparenti. Gli assessment e i percorsi di sviluppo individualizzato sono gli strumenti principali per ottenere esattamente questo risultato. Fondamentale è anche preservare quello che si potrebbe definire il diritto all’errore costruttivo. L’imprenditore sa che per innovare bisogna accettare il rischio di sbagliare. Una struttura manageriale troppo rigida può uccidere questa propensione all’innovazione. Il mio background in business coaching mi ha spesso facilitato nella creazione di un ambiente in cui l’errore diventa occasione di apprendimento, non motivo di sanzione.
Si parla spesso di “leadership diffusa”. Ma concretamente, come si costruisce? E quali leve HR sono più efficaci per sviluppare una managerialità condivisa?
La leadership diffusa, sulla base della mia esperienza trentennale, non è certo un concetto teorico ma è una necessità operativa che ho dovuto implementare concretamente. Il primo elemento che ritengo fondamentale è quello dell’identificazione precoce del potenziale. Non si tratta solo di guardare alle performance attuali, ma di riconoscere in anticipo chi ha le caratteristiche per crescere in ruoli di leadership.
La lunga esperienza in selezione e valutazione ha affinato la capacità di vedere oltre le competenze tecniche attuali e riconoscere il potenziale di crescita. Ma soprattutto, mi ha insegnato che il potenziale di leadership si manifesta spesso in modi non convenzionali: nel modo in cui una persona gestisce una crisi, nel suo approccio ai colleghi in difficoltà, nella capacità di proporre soluzioni innovative.
Il secondo aspetto critico è la crescita per sfide progressive. Non si diventa leader dall’oggi al domani, e la mia esperienza mi ha mostrato l’importanza di creare percorsi di crescita che espongano gradualmente le persone a responsabilità crescenti. Avendo vissuto e gestito realtà molto diverse, dalla produzione ai servizi, ho sviluppato una visione trasversale che ora posso utilizzare per creare percorsi di crescita che consentano alle persone di maturare esperienze diversificate.
Ma c’è un ulteriore elemento che ritengo particolarmente importante: la capacità di vedere la leadership come fenomeno sistemico, non individuale. Un leader non esiste nel vuoto, esiste in relazione con il suo team, con i suoi pari, con i suoi superiori. Sviluppare leadership significa lavorare non solo sul singolo individuo, ma sull’intero ecosistema relazionale in cui il leader opera. Tra gli strumenti più potenti ed efficaci che ho utilizzato c’è sicuramente il “mentoring interno strutturato”. Non si tratta solo di definire affiancamenti informali, ma di creare sistemi strutturati in cui i leader senior diventano coach e mentor di quelli junior.
Un’altra dimensione cruciale è quella della comunicazione interna. In un momento di trasformazione, quanto conta saper comunicare bene e con continuità? E come lo fate nella vostra realtà?
La comunicazione durante la trasformazione è sicuramente una leva strategica indispensabile. Aver lavorato in contesti molto diversi mi ha mostrato che non esiste un approccio universale alla comunicazione: quello che funziona in Amazon può essere completamente inadeguato in una realtà come B.Kolor, e viceversa. La prima lezione è che la comunicazione del cambiamento non può essere episodica; è importante mantenere un flusso comunicativo costante e coerente.
Le persone hanno bisogno di capire non solo cosa sta cambiando, ma perché sta cambiando, quando cambierà, e soprattutto qual è il loro ruolo in questo cambiamento. Il vuoto comunicativo viene sempre riempito da supposizioni, voci di corridoio, paure, e questo può minare qualsiasi sforzo di trasformazione. Un altro aspetto è l’importanza della comunicazione bidirezionale; non si tratta solo di comunicare dall’alto verso il basso, ma di creare canali strutturati per raccogliere feedback, preoccupazioni, suggerimenti dal basso.
Ho imparato quanto sia importante ascoltare, anche quando quello che si sente non è sempre piacevole. Durante una trasformazione, le resistenze e le paure sono normali, e nasconderle sotto il tappeto non le fa sparire: le fa crescere. Un elemento che ritengo distintivo è l’attenzione alla “comunicazione simbolica”. Non si tratta solo di quello che si dice, ma di come lo si dice, quando lo si dice, chi lo dice, in quale contesto. Ogni scelta comunicativa invia un messaggio che va oltre il contenuto esplicito, e gestire questi messaggi impliciti è fondamentale per il successo della trasformazione; questo è l’approccio che sto applicando anche in quest’ultima esperienza lavorativa.
Ci racconta un caso concreto, anche difficile, in cui la funzione HR ha giocato un ruolo decisivo durante il cambiamento?
Quando penso a un momento in cui l’HR ha giocato un ruolo davvero decisivo durante il cambiamento, non posso non riferirmi alla mia esperienza nella gestione di tre piani di riduzione del personale che hanno coinvolto complessivamente circa 400 persone in Italcementi S.p.A.
Quello che rende questa esperienza particolarmente significativa è che non si è trattato di un episodio isolato, ma di un percorso che ho dovuto affrontare in momenti diversi della mia carriera, in contesti diversi, con sfide diverse. Questo mi ha dato una prospettiva unica su come gestire il cambiamento quando questo comporta dolore, perdite, difficoltà per le persone. Il primo elemento è la capacità di vedere oltre l’aspetto puramente procedurale. Certo, ci sono aspetti legali, contrattuali, sindacali da gestire, ma quello che ha fatto la differenza è stata la capacità di mantenere sempre al centro le persone, non i numeri.
Ognuna di quelle 400 persone aveva una storia, una famiglia, progetti, paure. L’HR ha fatto la differenza trasformando quello che poteva essere un freddo esercizio di riduzione dei costi in un processo il più possibile rispettoso della dignità delle persone coinvolte. L’esperienza nelle negoziazioni con sindacati e associazioni categoriali ha mostrato come la Funzione Risorse Umane possa essere il ponte tra le esigenze aziendali e la tutela dei lavoratori.
Non si è trattato di schierarsi da una parte o dall’altra, ma di trovare soluzioni che riconoscessero la legittimità delle esigenze di entrambe le parti. Ma forse l’aspetto più distintivo del mio approccio è stato l’investimento nell’outplacement e nella ricollocazione. Non mi sono limitato a gestire le uscite, ho investito tempo, energie e risorse per aiutare le persone a trovare nuove opportunità. Questo approccio non solo ha dimostrato rispetto per le persone coinvolte, ma ha anche preservato la reputazione aziendale e mantenuto un accettabile clima interno tra chi rimaneva. Chi ha visto come l’azienda trattava chi doveva andarsene ha capito che tipo di organizzazione era quella per cui continuava a lavorare.
Guardando avanti, quali sono secondo lei le competenze che un HR manager dovrebbe assolutamente coltivare per affrontare queste sfide organizzative complesse?
Per rispondere a questa domanda spero di non peccare di presunzione facendo riferimento alla mia evoluzione professionale, dove intravedo anticipate quelle che ritengo essere le competenze fondamentali per l’HR del futuro; non ho aspettato che il mercato me le richiedesse, ma le ho in qualche modo anticipate, intuendo dove stava andando la professione.
La prima competenza fondamentale è quella che definirei il coaching come mindset, non solo come strumento”. La certificazione EQA prima ed EIA Senior Practitioner poi non è solo una qualifica, è la dimostrazione di un approccio diverso alla gestione delle persone. Non si tratta più di amministrare risorse umane, ma di sviluppare potenziale umano.
Questo richiede la capacità di vedere oltre le performance attuali, di riconoscere possibilità di crescita, di creare conversazioni che generino insight e cambiamento.
La seconda competenza critica è quella sistemica. La mia formazione in Systemic Team Coaching mi ha dato la capacità di vedere l’organizzazione come un sistema complesso, non come somma di singoli individui. Questo è fondamentale perché i problemi organizzativi raramente hanno cause singole e soluzioni semplici. Servono persone capaci di vedere connessioni, interdipendenze, effetti sistemici delle scelte HR.
Un’altra competenza fondamentale è l’agilità cognitiva. La capacità di muoversi tra settori profondamente diversi – dalla chimica al beauty, dalla metalmeccanica alla logistica e all’e-commerce – credo sia la dimostrazione di una flessibilità mentale che è sempre più importante. Il mondo cambia velocemente, i modelli di business si evolvono, le aspettative delle persone si modificano. Serve un HR capace di adattarsi, di imparare velocemente, di applicare principi consolidati a contesti sempre nuovi.
La competenza digitale è ormai imprescindibile, non solo e non tanto nel senso di saper usare i software HR, ma nel senso di capire come la tecnologia può abilitare nuove modalità di gestione delle persone. La competenza più importante che emerge dal mio percorso è quella che definirei “la leadership di influenza”. Un HR Manager oggi non può più limitarsi a essere un esperto funzionale, deve essere un leader in grado di influenzare e orientare l’intera organizzazione. La mia esperienza mi ha mostrato che l’HR ha successo quando riesce a far capire a tutti nell’organizzazione che la gestione delle persone non è responsabilità esclusiva delle Risorse Umane, ma è una competenza che tutti i manager devono sviluppare.